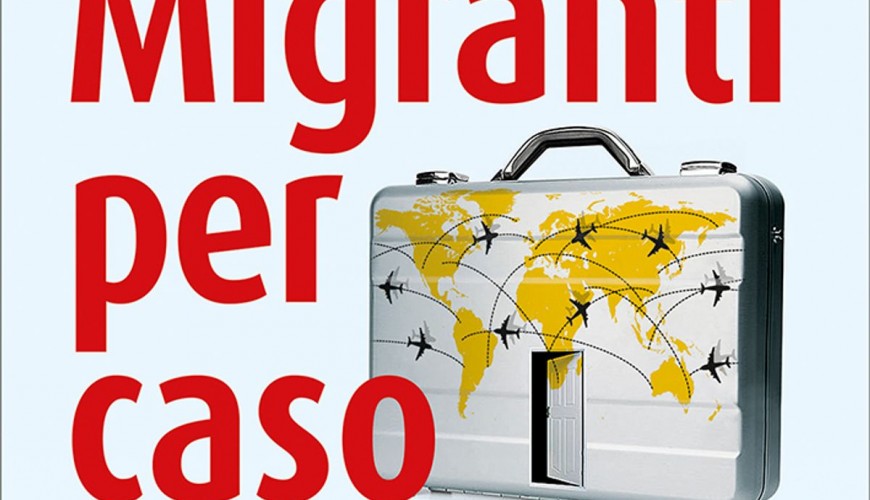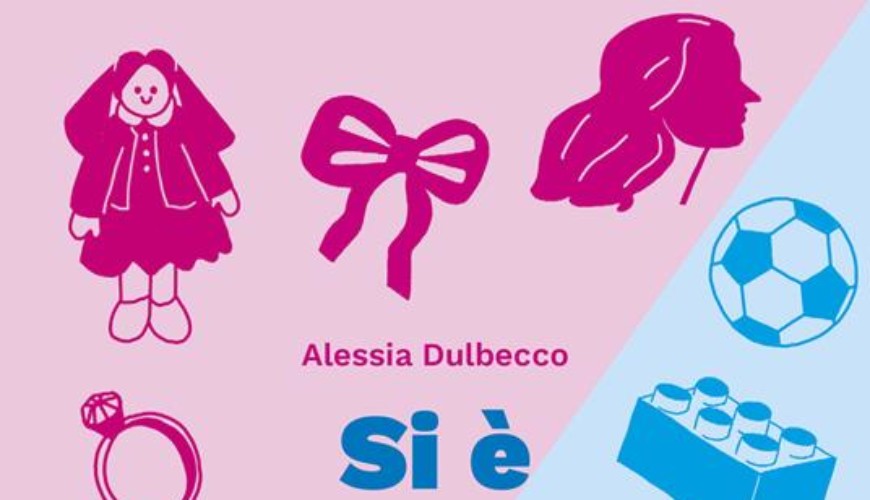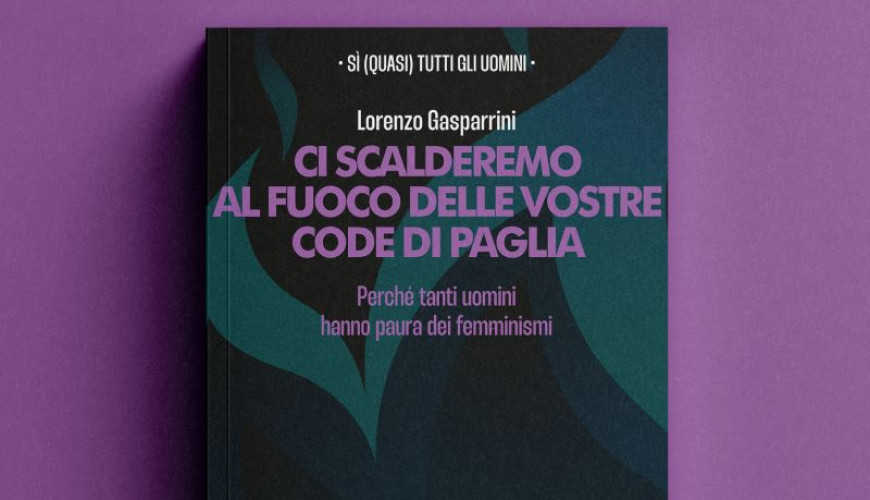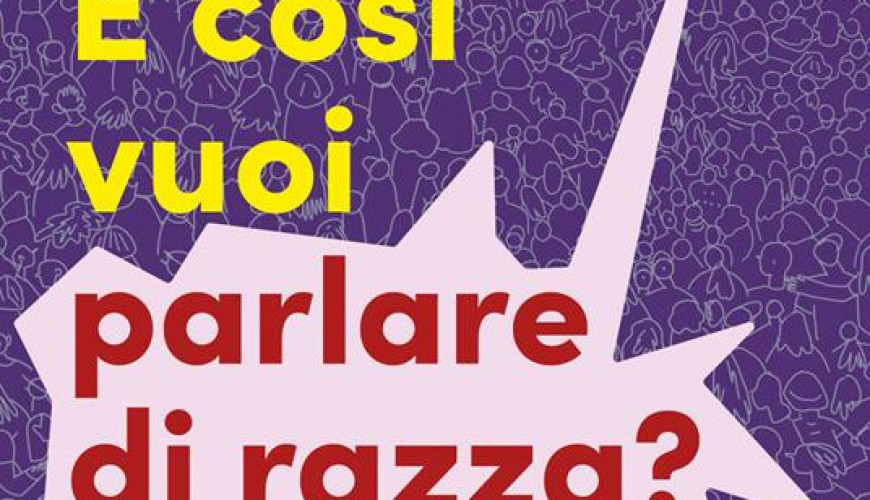Francesca Rigotti è filosofa e docente universitaria. Il suo ultimo libro si intitola “Migranti per caso. Una vita da expat” ed è pubblicato da Raffaello Cortina Editore, nella collana Temi.
Fin dal Prologo, Francesca Rigotti chiarisce che parlerà di migranti ed espatrio in qualità di osservatrice ma anche come diretta interessata: come si può definire infatti una donna «europea, bianca e istruita» che lascia Milano per andare a vivere in quella che un tempo era chiamata Germania dell’Ovest? Espatriata, migrante, immigrata, emigrata?
Sono tantissime le parole che definiscono «l’enorme fetta di umanità in movimento» su questo pianeta ma il nuovo termine è expat (abbreviazione di expatriate), da ex-patriare, allontanarsi dalla patria. Scherzando un po’ sulla probabile origine del suo cognome e sui momenti di vita ad esso legati, Francesca Rigotti inserisce nel suo libro alcuni testi con carattere tipografico diverso: brani autobiografici che parlano del suo lavoro, del suo compagno di vita, dei loro figli, del suo essere anche semplicemente donna e non per forza «madre di, figlia di, moglie di»; si parla tanto di donne, partendo anche dalle parole che Margaret Atwood fa pronunciare alla sua Penelope (vero, anche la «moglie di» Ulisse è un’expat “da matrimonio”), molto diverse dalla versione originale di Omero.
Tornando alla famiglia, si può scegliere ad esempio di emigrare attratti da offerte lavorative importanti (soldi) e, se uomini, in genere con donne e bambini a seguito come hidden immigrates – immigrati nascosti, cioè simili agli altri abitanti del paese di arrivo ma portatori di una cultura diversa.
Per parlarci di migranti politici ed economici, confini tra Stati e diritto di movimento, oltre a citare spesso la figura di Ulisse, la filosofa collega Cicerone, Kant, Miller e li pone a contrasto con la Carta di Lampedusa del 2014.
In quanto studiosa di analogie, immagini e simboli, l’autrice dedica tre interessantissimi capitoli alle metafore della migrazione (legate all’acqua oppure a radici, dighe, muri, porte…), partendo anche da un suo articolo del 1997 che però sembra scritto proprio oggi, per ricordarci che l’ “ondata migratoria”, la “marea umana”, il “flusso di migranti” non è emergenza, come narrano i mass media e la politica (Berlusconi parlò di “tsunami umano”) ma è storia. Si parla dei muri dei quartieri residenziali chiusi (gated communities) o dei famosi muri eretti dalle autorità per rispondere in modo immediato al fenomeno migratorio ma incapaci di fornire risposte vere. Infine le radici, quelle che simboleggiano origine, crescita, attaccamento, secondo alcuni studiosi anche staticità e immobilismo (Maurizio Bettini, citato più volte dall’autrice). Il libro termina con la grande storia dell’intellettuale Vilém Flusser.
Purtroppo manca una bibliografia riassuntiva finale, quindi i tanti riferimenti vanno ricordati; credo quindi che tornerò di tanto in tanto a sfogliare questo libro, poiché in poche pagine Francesca Rigotti ci regala una riflessione intensa, personale, sincera, aggiornatissima, intrecciando linguistica, filosofia, psicologia, mito e letteratura, religione, storia…insomma, si avverte il sentimento di urgenza nel parlare di filosofia della migrazione per «cercare, più che soluzioni, conforto e senso». Così come le ha insegnato un suo professore, Walter Euchner, quando era una giovane docente all’Università di Gottinga: «se attorno a noi succedono eventi importanti […], lasci perdere la programmazione e intervenga su quelli».

Francesca Rigotti
Casa editrice
Raffaello Cortina
Anno
2019
Genere
saggistica
Formato
Brossura
Pagine
132
ISBN
9788832850970